filmscoop.it blog, blog di cinema, news, interviste, approfondimenti, notizie dai festival, serie tv

al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Reason to believe, "Nebraska"
Pubblicato il 28/01/2014 18:32:59 da kowalsky
"STILL AT THE END OF THE VERY HARD DAY PEOPLE FIND SOME REASON TO BELIEVE"
Come un fantasma che evoca, nel titolo, un celebre disco di altri fantasmi. "Nebraska", l'album di Bruce Springsteen, uno degli album più lirici, struggenti e speculari della storia del rock, non "suona" mai nel nuovo film di Alexander Payne, ma è come se quelle canzoni, quelle storie lì cantate dal Boss in solitaria (dis)armonia con se stesso, filtrassero tutte o quasi nelle immagini del film.
Siamo nel 2013, ma potremmo benissimo ritrovare il Woody Guthrie di tanti decenni fa, i romanzi di Steinbeck e l'America della secessione, con la provincia cronica, come direbbe una band italiana, che segue il suo immutabile corso del tempo, cent'anni e non sentirli.
Lo stato del Nebraska, che in gergo significa "acqua calma", è un confine di circa due milioni di abitanti, e il Woody Guthrie di un tempo oggi si chiamerebbe Woody Grant. E ha il volto scavato e astratto di Bruce Dern, con la sua andatura dinoccolata, e quegli occhi che comunicano la propria ingenua "reason to believe", quando intraprende un lungo viaggio con il figlio alla ricerca di quell'effimero "tesoro" che tenta ostinatamente di ritirare. Ovviamente non esiste alcuna vincita milionaria, ma esistono uomini disposti ancora a "credere". Bruce Dern è l'equivalente italiano di un vecchio rimbambito, perché il film non è esportabile nel vuoto della memoria o della cultura, e molti spettatori faticheranno a intuire il senso anche "politico" della sua ricerca. L'anziano viandante, accompagnato dal figlio, ricorda per certi versi la Geraldine Page di In viaggio verso Bountiful, con quella forte dimensione terrena (legata ai ricordi e al suo antico habitat umano) che proprio perché illusoria e fine a se stessa appare incomprensibile, folle, geriatrica, se non addirittura demente.
Bruce Dern, come molti sanno, esordì nel cinema con Kazan, Hitchcock e Aldrich, e già inquietò le folle nei panni di un molesto marinaio nel film Marnie. Nella sua carriera è stato spesso equiparato a psicopatici killer e assassini di varia natura, grazie forse al suo aspetto brutale, a quella faccia tagliata con il rasoio, alla vaga schizofrenia del suo sguardo. Ma gli occhi di Woody Grant sembrano assenti, eppure comunicano la facoltà di non rispondere, quell'urgenza di "credere" per se stesso e per i suoi figli, come quei tanti vecchi che reclamano di essere ascoltati, ma sanno di non potersi esprimere, perché tanto è inutile, non verranno mai capìti. Anche per questa ragione la visione di "Nebraska" è caldamente consigliata, per vedere (o sentire) cosa possa esserci nelle aspettative di una persona anziana: forse solo (e non è poco) la paura di andarsene per sempre da questo mondo senza lasciare una minima traccia nelle persone che ama.
E' un cinema, questo di Payne, che parla dei Padri, come pionieri e fondatori di una Nazione - ma questo lo capiranno di più certi americani - come profeti illusi e disincantati di quel Sogno (Americano, ma potrebbe ampliarsi al mondo intero) che fa dell'esistenza una o più ragioni per credere, fino in fondo.
Nebraska è il nome di una nazione e di un celebre disco che, malgrado tutto, ha avuto più risonanza tra gli outsiders che non tra i fans di Springsteen. E' un road movie che precede ogni istante come se fossimo davanti al fotogramma di una singola canzone. Come quella che invita a rivedere i propri cari scomparsi per varie ragioni, "everything dies baby that's a fact but everything that dies someday comes back", ed è dove Woody, vecchio alcolizzato, ritorna, con il suo carico di speranze, ma non alla maniera di un giovane à la Johnny 99, che uccide un uomo perché ha l'occasione di riscattare solo così una situazione economica senza scampo. E' come il Lupo solitario del film di Sean Penn ispirato a "Highway Patrolman" sempre di Springsteen, che cerca il suo "oro", come i vecchi pionieri dei secoli scorsi, per riscattarsi come padre e come uomo.
Dovete provare a cercare in quegli occhi: vi diranno qualcosa.
Ma la fauna dei personaggi, quasi ricca delle proprie personali meschinità, è quel mondo di "mostri" partoriti, come suggeriva il Boss, dall'incompetenza e dalle bugie dei governi statunitensi. E' un mondo che richiama il cinema del primo Bogdanovich, o anche Hal Ashby e altri ancora. Quel miraggio terreno, forse, è l'unica Isola che non c'è in grado di sostenere la speranza e forse una bugia che vale più della stessa verità. Il mondo crea un'umanità che guarda passivamente le partite di football in televisione, che assiste al trionfo degli altri e, senza saperlo, alla propria frustazione quotidiana. Come in un film di Lynch ma senza oscure metafore, come la sagoma andante di questo settantenne/ottantenne alla ricerca autentica di un'illusione che lo possa confortare.
La ragione di credere di Woody Grant è la stessa di coloro che si aggrappano alla vita fino all'istante in cui sembra volare via. Per questo è un bagaglio enorme di emozioni celate, che la gente più non ascolta"
Come un fantasma che evoca, nel titolo, un celebre disco di altri fantasmi. "Nebraska", l'album di Bruce Springsteen, uno degli album più lirici, struggenti e speculari della storia del rock, non "suona" mai nel nuovo film di Alexander Payne, ma è come se quelle canzoni, quelle storie lì cantate dal Boss in solitaria (dis)armonia con se stesso, filtrassero tutte o quasi nelle immagini del film.
Siamo nel 2013, ma potremmo benissimo ritrovare il Woody Guthrie di tanti decenni fa, i romanzi di Steinbeck e l'America della secessione, con la provincia cronica, come direbbe una band italiana, che segue il suo immutabile corso del tempo, cent'anni e non sentirli.
Lo stato del Nebraska, che in gergo significa "acqua calma", è un confine di circa due milioni di abitanti, e il Woody Guthrie di un tempo oggi si chiamerebbe Woody Grant. E ha il volto scavato e astratto di Bruce Dern, con la sua andatura dinoccolata, e quegli occhi che comunicano la propria ingenua "reason to believe", quando intraprende un lungo viaggio con il figlio alla ricerca di quell'effimero "tesoro" che tenta ostinatamente di ritirare. Ovviamente non esiste alcuna vincita milionaria, ma esistono uomini disposti ancora a "credere". Bruce Dern è l'equivalente italiano di un vecchio rimbambito, perché il film non è esportabile nel vuoto della memoria o della cultura, e molti spettatori faticheranno a intuire il senso anche "politico" della sua ricerca. L'anziano viandante, accompagnato dal figlio, ricorda per certi versi la Geraldine Page di In viaggio verso Bountiful, con quella forte dimensione terrena (legata ai ricordi e al suo antico habitat umano) che proprio perché illusoria e fine a se stessa appare incomprensibile, folle, geriatrica, se non addirittura demente.
Bruce Dern, come molti sanno, esordì nel cinema con Kazan, Hitchcock e Aldrich, e già inquietò le folle nei panni di un molesto marinaio nel film Marnie. Nella sua carriera è stato spesso equiparato a psicopatici killer e assassini di varia natura, grazie forse al suo aspetto brutale, a quella faccia tagliata con il rasoio, alla vaga schizofrenia del suo sguardo. Ma gli occhi di Woody Grant sembrano assenti, eppure comunicano la facoltà di non rispondere, quell'urgenza di "credere" per se stesso e per i suoi figli, come quei tanti vecchi che reclamano di essere ascoltati, ma sanno di non potersi esprimere, perché tanto è inutile, non verranno mai capìti. Anche per questa ragione la visione di "Nebraska" è caldamente consigliata, per vedere (o sentire) cosa possa esserci nelle aspettative di una persona anziana: forse solo (e non è poco) la paura di andarsene per sempre da questo mondo senza lasciare una minima traccia nelle persone che ama.
E' un cinema, questo di Payne, che parla dei Padri, come pionieri e fondatori di una Nazione - ma questo lo capiranno di più certi americani - come profeti illusi e disincantati di quel Sogno (Americano, ma potrebbe ampliarsi al mondo intero) che fa dell'esistenza una o più ragioni per credere, fino in fondo.
Nebraska è il nome di una nazione e di un celebre disco che, malgrado tutto, ha avuto più risonanza tra gli outsiders che non tra i fans di Springsteen. E' un road movie che precede ogni istante come se fossimo davanti al fotogramma di una singola canzone. Come quella che invita a rivedere i propri cari scomparsi per varie ragioni, "everything dies baby that's a fact but everything that dies someday comes back", ed è dove Woody, vecchio alcolizzato, ritorna, con il suo carico di speranze, ma non alla maniera di un giovane à la Johnny 99, che uccide un uomo perché ha l'occasione di riscattare solo così una situazione economica senza scampo. E' come il Lupo solitario del film di Sean Penn ispirato a "Highway Patrolman" sempre di Springsteen, che cerca il suo "oro", come i vecchi pionieri dei secoli scorsi, per riscattarsi come padre e come uomo.
Dovete provare a cercare in quegli occhi: vi diranno qualcosa.
Ma la fauna dei personaggi, quasi ricca delle proprie personali meschinità, è quel mondo di "mostri" partoriti, come suggeriva il Boss, dall'incompetenza e dalle bugie dei governi statunitensi. E' un mondo che richiama il cinema del primo Bogdanovich, o anche Hal Ashby e altri ancora. Quel miraggio terreno, forse, è l'unica Isola che non c'è in grado di sostenere la speranza e forse una bugia che vale più della stessa verità. Il mondo crea un'umanità che guarda passivamente le partite di football in televisione, che assiste al trionfo degli altri e, senza saperlo, alla propria frustazione quotidiana. Come in un film di Lynch ma senza oscure metafore, come la sagoma andante di questo settantenne/ottantenne alla ricerca autentica di un'illusione che lo possa confortare.
La ragione di credere di Woody Grant è la stessa di coloro che si aggrappano alla vita fino all'istante in cui sembra volare via. Per questo è un bagaglio enorme di emozioni celate, che la gente più non ascolta"
Categorie: Generi drammatico, Cinema approfondimenti
Commenti: 4, ultimo il 06/02/2014 alle 13.57.33 - Inserisci un commento
Il futuro
Pubblicato il 29/11/2013 09:56:29 da BarbieXanax
Una collaborazione Italia-Cile per un film tratto dall'opera Un romanzetto canaglia di Roberto Bolaño.
Non mi ha convinto pienamente, se vi va di sapere perché ecco la mia video-recensione.
Buona visione:
Categorie: Generi drammatico, Cinema approfondimenti
Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento
Sarebbe stato facile
Pubblicato il 25/11/2013 09:34:19 da BarbieXanax
Ho cercato di perdonare questo film sotto più punti ma non ce l'ho fatta, per me è film più brutto dell'anno. Se non temete nulla vi sfido a cliccare Play.
Buona visione:
Buona visione:
Categorie: Generi commedia
Commenti: 17, ultimo il 26/02/2014 alle 18.15.09 - Inserisci un commento
Giovani ribelli
Pubblicato il 20/11/2013 09:50:34 da BarbieXanax
L'attore celebre per Harry Potter torna al cinema con una nuova sfida, la credibilità nel panorama indie con un film sulla beat generation, secondo me con ottimi risultati e secondo voi?
Categorie: Generi biografico, Cinema approfondimenti
Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento
VEDOVO O ASPIRANTE?
Pubblicato il 18/10/2013 09:41:24 da peucezia
1959: pieno boom economico. Il duo Dino Risi regista e Rodolfo Sonego sceneggiatore, coadiuvati da uno stuolo di attori di primo livello (in primis la coppia Sordi-Valeri) unita all'ottimo team di caratteristi, confezionano un prodotto cinematografico che a distanza di cinquanta anni fa ancora ridere e discutere: Il vedovo.
Risi nella sua ironia nera mette alla berlina l'Italietta che pure cresce grazie al miracolo economico ma anche l'indissolubilità matrimoniale che è spesso mal sopportata, fino a voler giungere a soluzioni estreme pur di sbarazzarsi di una situazione diventata difficile da gestire.
I due protagonisti sono impeccabili: lei mammona, eppure anche mascolina e rigida, lui maramaldo qualunquista, abbastanza incapace, eppure animato da velleità irragiungibili.
La storia ha colpito l'immaginazione di molti sceneggiatori, i quali hanno spesso fatto delle citazioni al film (da ricordare la pellicola spagnola Crimen perfecto che ripropone la scena dell'ascensore).
A distanza di cinquant'anni, essendo in vena di amarcord (o forse a corto di idee) il regista Massimo Venier (che in altri tempi poteva fregiarsi della qualifica di "onesto artigiano" ) ha pensato di ispirarsi al mitico "Vedovo" per una pellicola che sta al film di Risi come il cavolo a merenda.

In Aspirante vedovo Luciana Littizzetto è sì pungente ma ahimè riesce ad attirarsi le antipatie degli spettatori per l'atteggiamento assolutamente cinico dettato anche dalla vocina querula. Altresì De Luigi, sguardo perso nel vuoto e atteggiamento da cucciolo spaurito, non riesce nemmeno nell'iperuranio a riproporre la verve caustica del mitico Albertone e fa quindi male sapere che si chiama come Sordi nel film di Risi: Alberto Nardi.
Manca il piano diabolico che nel film di Risi occupa una buona parte della storia, manca la sana cattiveria che qui si trasforma in un cinismo senza sugo. Mancano i grandi veri caratteristi degli anni Cinquanta sostituiti con attori comprimari che recitano asetticamente la loro parte senza suscitare la minima emozione.
Un compitino svolto senz'infamia e senza lode che strappa qualche sorrisino stiracchiato sul momento ed è pronto a farsi dimenticare al più presto... peccato. Ma sì sa, nel cinema la regola di Paganini, anche se sempre si vìola, andrebbe rispettata: mai fare il bis se la prima è riuscita bene...
Risi nella sua ironia nera mette alla berlina l'Italietta che pure cresce grazie al miracolo economico ma anche l'indissolubilità matrimoniale che è spesso mal sopportata, fino a voler giungere a soluzioni estreme pur di sbarazzarsi di una situazione diventata difficile da gestire.
I due protagonisti sono impeccabili: lei mammona, eppure anche mascolina e rigida, lui maramaldo qualunquista, abbastanza incapace, eppure animato da velleità irragiungibili.
La storia ha colpito l'immaginazione di molti sceneggiatori, i quali hanno spesso fatto delle citazioni al film (da ricordare la pellicola spagnola Crimen perfecto che ripropone la scena dell'ascensore).
A distanza di cinquant'anni, essendo in vena di amarcord (o forse a corto di idee) il regista Massimo Venier (che in altri tempi poteva fregiarsi della qualifica di "onesto artigiano" ) ha pensato di ispirarsi al mitico "Vedovo" per una pellicola che sta al film di Risi come il cavolo a merenda.

In Aspirante vedovo Luciana Littizzetto è sì pungente ma ahimè riesce ad attirarsi le antipatie degli spettatori per l'atteggiamento assolutamente cinico dettato anche dalla vocina querula. Altresì De Luigi, sguardo perso nel vuoto e atteggiamento da cucciolo spaurito, non riesce nemmeno nell'iperuranio a riproporre la verve caustica del mitico Albertone e fa quindi male sapere che si chiama come Sordi nel film di Risi: Alberto Nardi.
Manca il piano diabolico che nel film di Risi occupa una buona parte della storia, manca la sana cattiveria che qui si trasforma in un cinismo senza sugo. Mancano i grandi veri caratteristi degli anni Cinquanta sostituiti con attori comprimari che recitano asetticamente la loro parte senza suscitare la minima emozione.
Un compitino svolto senz'infamia e senza lode che strappa qualche sorrisino stiracchiato sul momento ed è pronto a farsi dimenticare al più presto... peccato. Ma sì sa, nel cinema la regola di Paganini, anche se sempre si vìola, andrebbe rispettata: mai fare il bis se la prima è riuscita bene...
Categorie: Cinema in uscita, Cinema riflessioni sparse, Cinema approfondimenti
Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento
In programmazione
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
40 secondiabout luisallevi - back to lifeammazzare stancaanemoneanna (2025)articolo 1attitudini: nessunaavatar - fuoco e cenerebobo'breve storia d'amorebrunello - il visionario garbatobuen caminobugoniabuon viaggio, mariebus 47caravaggio a roma - il viaggio del giubileocarmen e' partitac'e' un posto nel mondoc'era una volta mia madrecinque secondidead of winterdepeche mode: mdie my lovedj ahmetdracula - l'amore perdutodreams (2025)due famiglie, un funeraleeddingtoneternity (2025)evenfantasma in guerrafather mother sister brotherfilmlovers!five nights at freddy's 2frankenstein (2025)fuori la verita'gioia miagiovani madri
NEW
hambreheidi - una nuova avventurai colori del tempo R
il maestro (2025)il mio nome e' nevenkail mostro (2025)il primo figlioil principe della folliail profeta (2025)il rapimento di arabellail sentiero azzurroin the hand of danteio sono rosa riccijay kellyjujutsu kaisen: esecuzionela ballata di un piccolo giocatorela camera di consigliola chitarra nella roccia - lucio corsi dal vivo all’abbazia di san galganola divina di francia - sarah bernhardtla famiglia halloweenla grande paura di hitler. processo all'arte degeneratala mano sulla culla (2025)la mia famiglia a taipeila piccola ameliela ragazza di ghiaccio NEW
la villa portoghesela vita va cosi'laghat - un sogno impossibilel'anno nuovo che non arrivaleopardi & col'illusione perfetta - now you see me 3lo schiaffo (2025)lo sconosciuto del grande arcol'ombra del corvolupin the iiird: the movie - la stirpe immortalemonsieur aznavourne zha - l'ascesa del guerriero di fuoconguyen kitchennino. 18 giornino other choice - non c'e' altra sceltanoi e la grande ambizionenorimbergaoi vita miaorfeo (2025)paw patrol: missione nataleper tepiero pelu’. rumore dentropredator: badlandspredators (2025)primavera (2025)put your soul on your hand and walkqui staremo benissimoradio solaire - radio diffusion ruraleregretting you - tutto quello che non ti ho dettoricardo e la pitturarino gaetano - sempre piu' bluriproberto rossellini - piu' di una vitascarletsemplice clienteshelby oaks - il covo del malesiamo in un film di alberto sordi? NEW
siratsognando rosso NEW
song sung blue - una melodia d'amorespongebob - un'avventura da piratispringsteen - liberami dal nullathe age of disclosurethe encampments - gli accampamentithe mastermindthe perfect neighbor: la vicina perfettathe running manthe smashing machinethe teacher (2023)the toxic avengerthe ugly stepsistersto a land unknowntoni, mio padretony, shelly e la luce magicatroll 2 (2025)tua madre NEW
ultimo schiaffoun inverno in coreaun semplice incidenteun topolino sotto l'alberouna di famigliauna famiglia sottosoprauna ragazza brillantevasvita privata (2025)wake up dead man - knives outwicked - parte 2zootropolis 21068365 commenti su 53008 film
Ultimi film inseriti in archivio
13 JOURS, 13 NUITSALIEN: PIANETA TERRA - STAGIONE 1BELFAGOR OVVERO IL FANTASMA DEL LOUVRECONAN L'AVVENTURIEROFREWAKAGENITORI A TUTTO CAMPO - STAGIONE 1HAI PAURA DEL BUIO? - STAGIONE 10HAI PAURA DEL BUIO? - STAGIONE 9HEY VERN, IT'S ERNEST!HOUSE OF GUINNESS - STAGIONE 1INTERVISTA COL VAMPIRO - STAGIONE 1INTERVISTA COL VAMPIRO - STAGIONE 2IT: WELCOME TO DERRY - STAGIONE 1KEEPERLA CREATURA DI GYEONGSEONG - STAGIONE 2L'AMICA GENIALE - STAGIONE 1L'AMICA GENIALE - STAGIONE 2L'AMICA GENIALE - STAGIONE 3L'AMICA GENIALE - STAGIONE 4MAN VS. BABY - STAGIONE 1MERCOLEDI' - STAGIONE 2MONSTER - LA STORIA DI ED GEINMONSTERS - LA STORIA DI LYLE ED ERIK MENENDEZNOUVELLE VAGUESCUOLA DI POLIZIA - STAGIONE 1SICILIA EXPRESS - STAGIONE 1SISU - ROAD TO REVENGETASK - STAGIONE 1TAXI BROOKLYN - STAGIONE 1THE HUNCHBACK OF NOTRE DAMETHE PROFESSIONALTHE WALKING DEAD: DARYL DIXON - STAGIONE 3UNTAMED - STAGIONE 1
Ultimo film commentato
Ultimo post blog
OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater
Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater
Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...
Speciali
Ultime recensioni inserite
in sala
IL MAESTRO (2025)
 Regia: Andrea Di Stefano
Regia: Andrea Di StefanoInterpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia
Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
 Regia: Kathryn Bigelow
Regia: Kathryn BigelowInterpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller
Recensione a cura di The Gaunt
archivio
SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA
 Regia: Tim Fehlbaum
Regia: Tim FehlbaumInterpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier
Genere: drammatico
Recensione a cura di The Gaunt
NOSFERATU (2024)
 Regia: Robert Eggers
Regia: Robert EggersInterpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark
Genere: horror
Recensione a cura di Harpo
Ultima biografia inserita
Casualmente dall'archivio
Novità e Recensioni
Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!



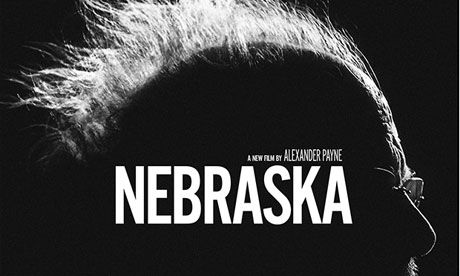



 Demenziale ed infantile ma anche tremendamente divertente.
Demenziale ed infantile ma anche tremendamente divertente.

