filmscoop.it blog, blog di cinema, news, interviste, approfondimenti, notizie dai festival, serie tv

al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Tutti i post per la categoria: Serie TV in uscita
"House of Cards": salve, Netflix
Pubblicato il 08/02/2013 10:51:19 da K.S.T.D.E.D.

Interessante, “House of Cards”, non solo per il prodotto in sé ma anche per la scelta da parte di Netflix – società statunitense che da qualche anno propone un servizio streaming dietro abbonamento – di lanciare un prodotto seriale senza costringere lo spettatore ad attendere i tempi di programmazione. Sì, strano a dirsi, la Netflix ha pubblicato in rete l'intera prima stagione di HoC in una sola volta. Molti saranno entusiasti di questa scelta, io personalmente ne farei l'ottava meraviglia del creato. Da appassionato di serie televisive ho sempre odiato e ritenuto davvero troppo riduttiva la programmazione settimanale. Non aiuta a godere del prodotto completo, si guardano circa 40 minuti ogni settimana, ossia il tempo di entrare all'interno di quanto raccontato che già ci si trova ad uscirne e a dover aspettare altri sette giorni. Non è un caso che abbia sempre optato per l'attesa della fine della stagione, e per la visione della stessa solo successivamente, secondo tempi scelti unicamente da me.
Si potrebbe pensare, abituati alla normale programmazione, che una scelta simile nasconda un prodotto magari non in grado di competere con i grandi. Non si butta lì una gallina dalle uova d'oro come se niente fosse. E in realtà, invece, è proprio così, perché HoC si rivela già dopo la prima puntata un prodotto che non solo ai grandi non ha nulla da invidiare, ma che è capace di farne vacillare più d'uno.
La narrazione segue le vicende di un classico politico senza scrupoli, Frank Underwood. Si è costruito giorno dopo giorno il suo posto al fianco del presidente degli Stati Uniti neoeletto, sì da ottenere l'ambito posto di Segretario di Stato. Dopo la vittoria gli viene comunicato che si è scelto di dare quella poltrona ad un'altra persona, e questo ad Underwood non piacerà affatto, né tanto meno ci passerà su come se nulla fosse. Lo si legge in una maniera alquanto chiara nello sguardo di Kevin Spacey
, che smette per l'occasione di essere Kevin Spacey e diviene Underwood. Chiariamo immediatamente, infatti, che la sua prova è straordinaria. Certo, la bravura dell'attore è nota, ma ciò non vieta di meravigliarsene ogni volta. Il personaggio è suo dopo poco più di 60 secondi, ossia quando rivolgendosi allo spettatore dice: “I have no patience for useless things”. Già, HoC tra le altre cose si distingue anche per le esternazioni che il protagonista rivolge a chi guarda (senza che vi sia alcun cambiamento nell'ambientazione), spesso spiegando in maniera tagliente cosa sta accadendo, cosa accadrà e perché. E diciamocelo francamente, in un intreccio politico non del tutto semplice, e anche abbastanza veloce, serve abbastanza, altro che critiche sulle varie forme di spiegone. Qui è decisamente utile. E poi Spacey, enorme, lo fa in modo magnetico, quindi va benissimo così.

Altro nome interessante: Beau Willimon. Co-sceneggiatore de “Le Idi di Marzo”, anch'esso un thriller politico, è colui che si è occupato di concretizzare l'intenzione della Netflix di proporre questo rifacimento della serie originale. Dà al prodotto lo stesso volto del film diretto da Clooney, quell'espressione disillusa, quella fotografia livida e quel portamento assai elegante. Se nel caso de “Le idi di Marzo”, tuttavia, qualcosa nella sceneggiatura zoppicava, qui invece la velocità di crociera si assesta su valori ben più alti, senza intenzione alcuna di discostarsene, se non verso l'alto. Ancora: David Fincher. Produttore esecutivo, tra gli altri, e regista dei primi due episodi. Ora, basta tenere a mente cosa ha combinato in “The Social Network”, rendendo una storia che minacciava le palle a km di distanza, una storia al contrario quanto mai scorrevole e dal ritmo insospettabile. Qui propone grosso modo la stessa regia, dettando tempi e modi ai quali si adatterà la regia degli episodi successivi. Chiara, supportata da un montaggio fluido, veloce quanto basta, pulita e concentrata sui personaggi, sì da non farsi sfuggire espressione alcuna. Del resto sono loro la serie, in questo caso più che in altri; loro e il loro pantano di dinamiche melmose e maleodoranti, ma vestite di tutto punto.
Tra modi attenti, immagine curata e fascino di facciata, infatti, si nascondono ragnatele intessute in maniera non semplicemente cinica, ma spregevole, solo apparentemente magnetica ma realmente nauseante, illuminate da una luce fredda minacciata solo a tratti da sorgenti calde in grado di resistere giusto il tempo di spegnersi sotto i colpi del gelo circostante. Massima espressione di ciò è il rapporto tra Frank e sua moglie, che non a causa mostra a tratti segni di cedimento più o meno contenuto, conseguenza di un malessere che minaccia di esplodere alla minima crepa, serpeggiando tra gli innumerevoli e spesso velenosi scambi. Colonne portanti, quest'ultimi, di dialoghi onnipresenti, attributo principale dell'intero prodotto. Ad essi il compito, anche, di calpestare ogni aspetto umano che cerca di farsi strada durante il racconto, seppur, è ovvio, non riusciranno a farlo a lungo. Non è possibile nella vita reale, né qui. Ed è questo che suggerirà la direzione da seguire alla seconda stagione.
La Netflix si presenta quindi in grande stile, con un prodotto che come si scriveva poc'anzi non ha nulla da invidiare a nessuno – salvo forse qualche caduta di stile, piccola ma evidente se confrontata con la gestione impeccabile di tutto il resto. Mostra inoltre, la Netflix, gusto ulteriore ufficializzando l'intenzione di sviluppare, dopo 7 anni, una quarta stagione di “Arrested Development”, sit-com inspiegabilmente sottovalutata. Ed è anche il caso a questo punto di tener d'occhio la nuova serie televisiva che proporrà ad Aprile, “Hemlock Grove”, horror/thriller con Eli Roth come produttore esecutivo.
Categorie: Serie TV in uscita, Serie TV attori, Serie TV approfondimenti
Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento
Kubrick - Una storia porno
Pubblicato il 21/11/2012 08:36:24 da The Gaunt

Una web serie attualmente sta avendo un discreto successo in rete: Kubrick - Una storia porno, che può essere vista comodamente su youtube sul canale The Jackal. Ovviamente si tratta di un piccolo assaggio di tre parti per un totale di circa quaranta minuti. In poche parole quello che può essere definito un pilot televisivo. Interessante è la modalità di approccio, che salta direttamente le forche caudine di produttori e soprattutto distributori, per proporsi direttamente al pubblico e vedere se un certo prodotto può avere o meno riscontro.
Gli indici di ascolto televisivi possono andare a farsi benedire perchè in questa modalità certamente saranno importanti le visualizzazioni e la capacità degli autori di essere esaustivi nei confronti del pubblico. Il contatto diretto con quest'ultimo, fondamentale, elemento è importante perchè ti pone direttamente ad essere messo di fronte ad eventuali critiche negative, come dall'altro lato a ricevere dei suggerimenti preziosi per il miglioramento del prodotto. Vantaggi che comunque compensano gli svantaggi di operazioni di questo tipo.
Perchè Kubrick? Semplicemente un omaggio ad uno dei più grandi cineasti di sempre, che fra i suoi progetti mai realizzati c'era appunto la realizzazione di un film porno in grande stile, con una troupe professionista del cinema "ufficiale" e con un cast di attori che dovevano eseguire le loro performance sessuali senza l'ausilio di professionisti del settore porno.

Si tratta proprio di questo infatti, il porno. Se ne parla, si pratica, si disquisisce in molteplici dibattiti, ma televisione e cinema finora hanno fatto orecchie da mercante nel nostro belpaese. Kubrick – una storia porno non si propone di sdoganare il genere, infatti qui non c'è nulla di porno (non ancora, almeno) ma affrontare una moltitudine di argomenti attraverso uno sguardo inusuale e certamente poco battuto da fiction e cinema italiano.
La storia è molto semplice: tre giovani autori non riescono a trovare fondi per girare dei cortometraggi di impegno sociale, quando all'improvviso ottengono una risposta positiva dai numerosi curriculum inviati. Solo che una volta giunti dal produttore, scoprono che opera nel mondo del porno e gli offre una sostanziosa somma per girare un corto di cinque minuti in 48 ore.
Prende il via una sarabanda di situazioni comiche godibilissime, tra la scelta della location, i provini per la scelta dell'attore maschile (decisamente facile), i provini per l'attrice femminile (decisamente più difficile), la sceneggiatura che deve stare al passo con i tempi ed evitare clichè.
Il formato di questa serie è molto professionale, strizza l'occhio a Boris, ed offre un cast di attori sconosciuto ma in grado divertire grazie ad una buona caratterizzazione dei personaggi. Un prodotto a cui non manca una certa brillantezza che tiene il livello delle allusioni e dei doppi sensi al minimo consentito e che pone dei buoni spunti di base per trattare temi, come la sessualità in primis, che non sono certo da cestinare. Personalmente non mi è dispiaciuta affatto e dopo queste tre mini-parti, non manca lo "stimolo" per vedere come va a finire.
"Il mondo del porno sta morendo. E' colpa di un virus: si chiama AMATORIALE!"
Categorie: Serie TV in uscita, Serie TV news, Serie TV approfondimenti
Commenti: 2, ultimo il 21/11/2012 alle 19.55.04 - Inserisci un commento
Tra ’86 e ’90, This is England ’88.
Pubblicato il 09/11/2012 08:26:25 da K.S.T.D.E.D.

Nel 2006 Shane Meadows gira quello che insieme a “Dead man's shoes” è il suo film più riuscito. “This is England” è infatti l'espressione più sincera e sentita di una poetica cinematografica che delinea gran parte dei tratti distintivi del nuovo linguaggio filmico britannico, di cui Meadows è uno dei massimi esponenti. Quattro anni più tardi, il regista inglese decide per un'incursione nell'universo televisivo, che fortunatamente sta attirando a sé molti registi fino ad ora “confinati” al grande schermo; le virgolette sono d'obbligo ed è anzi necessario precisare: il pensiero di chi scrive è ben lontano dal considerare il cinema riduttivo o addirittura inferiore allo strumento televisivo; è al tempo stesso, tuttavia, particolarmente propenso ad elogiare le potenzialità insite nei prodotti seriali, ancora troppo etichettati come meno significativi, più semplicistici e non in grado di toccare le stesse vette raggiunte e raggiungibili da una classica pellicola cinematografica. Un'etichetta che definire fuori fuoco sarebbe riduttivo. Di esempi se ne potrebbero fare parecchi, ma non è il caso di andare troppo oltre considerando che proprio Meadows ha confermato appena un anno fa l'erroneità della classificazione di cui si sta scrivendo. Nel 2010, infatti, scrive e dirige per la televisione una miniserie in quattro puntate, riprendendo proprio "This is England", capolavoro che non tutti rischierebbero di rovinare ritoccandolo, peraltro non semplicemente con un classico sequel, ma addirittura optando per un diverso registro linguistico. Lui invece pensa bene di provarci e tira fuori una miniserie che non ha assolutamente nulla da invidiare alla quasi omonima pellicola. Potente quanto quest'ultima, “This is England '86” è senza mezzi termini meravigliosa.
Le basta davvero poco per riportare alla mente e al cuore dello spettatore la parte più emozionale della pellicola; quell'anima viscerale e viva che la rende così riuscita, così credibile e così vera. Un'inquadratura, una frase, un accento, come anche una canzone, una luce o un'espressione; si ritorna all'interno di un'atmosfera, pur essendone usciti ben quattro anni prima, senza sforzo alcuno, anzi meravigliandosi del fatto di esserci riusciti in un lasso di tempo così ristretto: Combo e Shaun in macchina, immersi in quella luce tutta inglese che il cinema di Meadows sembra afferrare con assoluta facilità; appena qualche scambio e “This is England” sembra non essersi mai concluso.
Del resto è quanto accade anche col recente “This is England '88”, altra miniserie in tre puntate andata in onda lo scorso anno in Inghilterra – presentata anche come seconda stagione della miniserie precedente.
Si apre con tre parentesi senza particolari cornici cinematografiche, una per ognuno dei tre personaggi più significativi: Lol, Woods e Shaun (con Smell). Il vocabolario e l'accento sono già sufficienti a riaprire le porte di un'atmosfera assai familiare; immediatamente dopo parte “What Difference Does It Make?” dei The Smiths, sulle parole di Margaret Thatcher che annuncia di avere la cura per quel “British Disease” che aveva messo in ginocchio la Gran Bretagna. È la prima di una veloce sequenza di istantanee che delineano gli anni '80 sulle note di una canzone suonata da un gruppo creatosi e scioltosi proprio in quegli anni. Le porte a questo punto più che aperte sono spalancate, diciamo anche scardinate, e ancora una volta ci si ritrova senza quasi accorgersene proprio lì dove Meadows intende portarci.
Niente di nuovo, comunque. Il regista inglese ci tiene particolarmente ad immergere le sue storie in un contesto socio-temporale riconoscibile al fine di dare spessore e credibilità a quanto raccontato. È uno degli aspetti in assoluto più riusciti di “This is England”. La scelta delle brevi sequenze in successione veloce è infatti quanto mai completa. Si passa dalle manifestazioni alla politica, dalla fame nel mondo alla presa di potere di futuri dittatori, dallo sport alla televisione, dai disastri alla vita quotidiana, dalle stragi all'euforia; non si potrebbe, al termine, restare fuori da quegli anni neanche volendo.

Anni di cambiamenti, quindi, che in gran Bretagna si portavano dietro gli strascichi di una crisi che aveva costretto la gente a scendere in piazza, a ricalcolare il proprio futuro come il proprio benessere. Un disagio che si riflette con forza anche in personaggi che ormai si è imparato a conoscere e che Meadows si preoccupa, come si diceva, di tenere ben incollati al contesto. La sequenza d'apertura è già per quel disagio, inquadrato sul volto di Lol, alle prese con i fantasmi di quanto accaduto al termine di “This Is England '86”. I giorni delle bravate, della vita sregolata, delle risse e delle stronzate sono finiti. Lol si sveglia alle 6.07 perché chiamata dalla figlia, Woods alle 7.30 per andare in ufficio, Shaun altrettanto presto per andare al college. Questa volta la miniserie sembra un racconto di formazione tardiva e resa difficile da un malessere o un'insoddisfazione quanto mai presenti. Il distacco dei tre protagonisti, non a caso, dalla vita in cui li abbiamo conosciuti non è solo emotivo ma anche concreto; non li si vede mai con il resto del gruppo, bensì da soli e diretti verso un cambiamento testardamente voluto ma non sentito (Woody), oppure imposto (Lol) o, ancora, né sentito né cercato ma neanche rifiutato (Shaun).
Il cambio di registro lo si avverte chiaramente. La spensieratezza che nonostante tutto si avvertiva in precedenza, questa volta non la si avverte più. I toni, al contrario, si incupiscono notevolmente, tanto che il grigiore britannico diviene anche più grigio. A smorzarli, solo quell'ironia che fortunatamente non viene mai meno. Meadows vuole descrivere l'incertezza ed il disagio non solo come fantasmi ma come presenze reali ed ingombranti; dà loro il volto di Mike, che pur essendo frutto dell'immaginazione di Lol non va via dall'inquadratura quando Lol esce fuori dalla stessa; la telecamera, anzi, resta ferma su di lui, facendo passare un'inquietudine difficile da ignorare.
È proprio la differenza sostanziale nelle atmosfere e nello spirito a rischiare di provocare nello spettatore un'apparente insoddisfazione. 'Apparente' perché in realtà una volta metabolizzata la serie appare assai coerente nel suo trascinare i protagonisti in un passaggio evolutivo fondamentale, che diviene chiaro in una delle frasi più significative pronunciate da Woody nel finale. Al termine, nel bene o nel male, i caratteri appaiono più consapevoli delle loro scelte, più consapevoli di se stessi; sembrano aver accettato i loro trascorsi ed essersi riappacificati con un presente che non non solo non stavano vivendo, ma che stavano addirittura rifiutando nascosti dietro chissà quali aspettative o delusioni.
Il metabolismo rende inoltre evidente quanto bene si adatti lo stile registico di Meadows al volto in parte nuovo di questo ennesimo capitolo. Il malessere e il senso di incompiutezza vengono descritti in maniera perfetta da quel suo sguardo tipicamente viscerale, diretto e potente; asciutto ma senza intenzione alcuna di rinunciare all'uso sistematico delle musiche come di quella fotografia ricercata ma mai eccessiva.

Del “This is England” che conosciamo a questa miniserie non manca nulla, quindi, se non una durata maggiore. Si ha infatti la sensazione che il tutto duri davvero poco e che con qualche altro episodio il risultato sarebbe stato ancor più convincente e a quel punto inattaccabile. Non è un caso che la risoluzione possa apparire per certi versi sbrigativa o comunque compattata fino a rientrare nel minutaggio, e probabilmente lo è; ciononostante la riuscita dello stesso non viene compromessa in nessun modo, grazie e all'aspetto ironico – affidato ad un personaggio, Woody, meravigliosamente a metà tra il credibile e il farsesco - che pochi sanno mischiare al dramma come sa fare Meadows, e ai sempre ottimi dialoghi e, più in generale, alla gestione registico-narrativa che rende Meadows il cineasta che è.
Tra qualche mese dovrebbero iniziare le riprese di “This is England '90”. Il 2013 ha già un punto a suo favore.
Categorie: Serie TV in uscita, Serie TV registi, Serie TV approfondimenti
Commenti: ancora nessun commento al post. Inserisci un commento
Restituiamo agli zombie il loro ruolo
Pubblicato il 07/11/2012 08:39:05 da K.S.T.D.E.D.
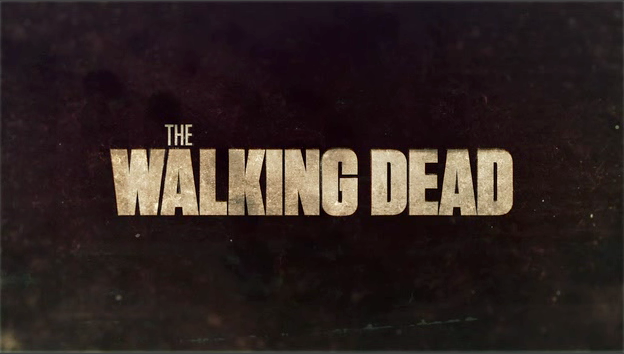
E poi così, di colpo, dopo 2 stagioni intere, o quasi, una serie che ha mostrato fin a quel momento limiti evidenti e debolezze di vario tipo, generando nello spettatore nient'altro che noia, irritazioni finanche cutanee e rabbia per l'enorme occasione sprecata, dimostra che in realtà non è che non fosse in grado di rendersi valida, semplicemente, forse, non le andava. Ho sempre criticato The Walking Dead con molta convinzione. E con la seconda stagione, poi, ho rincarato la dose ogni volta che me n'è capitata l'occasione. Era infatti diventata una sorta di Beautiful in un mondo zombiano senza zombie. Quest'ultimi erano quasi del tutto spariti e della trama non restavano che le dinamiche interpersonali tra caratteri di dubbio interesse, delineate attraverso dialoghi quanto meno deboli. Sono arrivato ad ipotizzare che lo scopo primo dei creatori fosse invero quello di metter su una critica al mondo odierno tratteggiando gli umani come i veri zombie, e gli zombie come la giusta cura, come coloro che avrebbero risollevato le sorti del mondo a forza di morsi. Si sarebbe spiegato così il perché della ormai quasi totale assenza di uccisioni violente di walkers e il perché della gestione così urticante dei personaggi.
Non abbandono mai una serie che ho cominciato o di cui ho visto più di qualche puntata. Deve sfinirmi sul serio perché io lo faccia. “The Walking Dead” è riuscita nell'impresa. A quattro puntate dalla fine della seconda ho lasciato, non ce la facevo più. Volevo mordere Convulsion-Shane, l'uomo che fa dieci scatti con il capo nel dire una sola frase. Di due parole. Volevo uccidere Rick e le sue pippe un tanto al chilo, la sua mancanza di carattere. Volevo picchiare sua moglie, per evitare di far nascere il bambino che portava in grembo in quel mondo di zombie vivi. Volevo prendere a pedate la testa del vecchio, perché parlava troppo, e quella di Hershel, perché semplicemente era troppo stupido per non morire. Davvero, ero arrivato al limite. Questo mesi addietro. Poi un paio di giorni fa decido di riprendere in mano le ultime 4 puntate della stagione, anche in vista dell'inizio della terza. Son sincero, lo avevo fatto con l'unica intenzione di venire qui a sfogarmi, scrivendone di ogni, e per riderci poi su, insieme. Ed è successo l'impossibile. Gli ultimi episodi mi son piaciuti; intendiamoci, qualche cazzata qua e là c'è sempre, ché altrimenti non sarebbe TWD, ma mi son piaciuti.
In appena 120 minuti la serie dimostra, come scrivevo inizialmente, che in realtà non era incapacità la sua, ma pigrizia o qualcosa di simile. Dimostra, in appena 120 minuti, che le posizioni dei vari personaggi, i loro caratteri non erano poco interessanti o poco credibili, né poco condivisibili e realistici, ma solo sviluppati male, senza la giusta introspezione. Il loro fascino potenziale cadeva sempre più rovinosamente sotto i colpi insistenti di dialoghi banali e di sequenze tutt'altro che efficaci. Ed è così che Rick inizia a tirar fuori un po' di carattere tra la fine della seconda stagione e l'inizio della terza; che il vecchio affianca un po' di pathos (trasmettendo di conseguenza una certa empatia) alle sue solite menate, che diventano pertanto meno menate e più riflessioni circostanziate e funzionali al racconto; che la cartolina un po' "Beautiful" inizia a strapparsi e il confine buoni/cattivi inizia a scemare; che Hershel tira fuori un po' di palle e comincia ad uccidere zombie con frasi ignoranti ma molto fighe tipo “Venite qui!!” manco fosse Rambo; che Carl inizia a smettere di comportarsi come un adulto e comincia finalmente a fare stronzate da bambino che più semplicemente si crede un adulto; che Shane, addirittura, diviene miracolosamente un personaggio di spessore. Dopo essere stato irritante nella sua pochezza per svariate puntate, fa un discreto salto di qualità con la fine della puntata 2x10: neanche 30 secondi, nessun dialogo, solo una serie di ideali campi-controcampi tra Shane e il se stesso riflesso in uno zombie solitario che vaga con un andamento che quasi sembra una ballata triste; il tutto accompagnato dall'ottima “Civilian” degli Wye Oak. La scena è inaspettatamente potente ed è il simbolo della differenza evidente di qualità tra la serie come la conoscevamo e gli ultimi episodi. “E ci voleva tanto?”, vien da chiedersi.

E così la gente comincia a morire seriamente, nel senso che le morti si sentono, perché i personaggi generano ora un minimo di empatia in più. Gli zombie tornano sullo schermo, tornano a mangiare gente, tornano ad essere il nemico anche per lo spettatore. Si accennava in precedenza che non si sta scrivendo affatto della ripresa del secolo, ma è giusto sottolinearla comunque, così come si sottolineano i limiti quando ci sono. La terza stagione è cominciata da poco e sembra avere anch'essa il suo ritmo, sembra essere discretamente godibile. Magari è stato un sussulto lungo qualche puntata, magari no. Speriamo di no.
Categorie: Serie TV in uscita, Serie TV riflessioni sparse, Serie TV approfondimenti, Serie TV sciocchezze
Commenti: 4, ultimo il 17/11/2012 alle 13.17.05 - Inserisci un commento
In programmazione
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
"cime tempestose" (2026)2 cuori e 2 capanne2000 metri ad andriivka28 anni dopo: il tempio delle ossaagata christian - delitto sulle nevianaconda (2026)andando dove non so - mauro pagani, una vita da fuggiasco
NEW
angelus tenebrarumben - rabbia animalebuen camino NEW
chopin, notturno a parigiconan, il ragazzo del futurocrime 101 - la strada del criminedivine comedydomani interrogodue procuratorielena del ghettoellie e la citta' di smeraldofilmlovers!fratelli demolitorigiulio regeni - tutto il male del mondogoat - sogna in grandegreenland 2: migrationhambrehamnet - nel nome del figlioil dono piu' preziosoil falsarioil filo del ricatto - dead man's wireil mago del cremlino - le origini di putinil profeta (2025) NEW
il suono di una cadutaio+tejastimari: il rifugiokrakenla gioiala graziala piccola ameliela scelta di josephla scomparsa di josef mengelela stanza di marianala terza voltala villa portoghese R
la voce di hind rajabl'agente segreto (2026)lavoreremo da grandile cose non dettel'infiltratalo sconosciuto del grande arco NEW
lo scurumarty suprememelaniamemoria di una rivoltamercy: sotto accusa NEW
midas manmio fratello e' un vichingo NEW
miroirs no. 3 - il mistero di lauramissione sheltermy father's shadowno other choice - non c'e' altra sceltanorth - la regina delle nevi NEW
per un po'pillion - amore senza frenipolvo seran - polvere di stelleprendiamoci una pausaprimavera (2025)rental family - nelle vite degli altrireturn to silent hillscarlet NEW
scream 7send helpsentimental valuesiratsong sung blue - una melodia d'amoresorry, babyspongebob - un'avventura da piratistray kids: the dominate experiencethe long walk - se ti fermi muorithe rip - soldi sporchi NEW
tienimi presenteultimo schiaffouna di famigliawhistle - il richiamo della mortewider than the sky - piu' grande del cielo1069564 commenti su 53178 film
Ultimi film inseriti in archivio
ASH - CENERE MORTALEIL RAGAZZO CHE GRIDAVA AL LUPO… MANNAROLA PETITE DERNIERELJUBA - CORPO E ANIMAOPERAZIONE FIFASALARYMAN KINTAROSQUADRA OMICIDI CHIAMA COBRATERMINATOR WOMANTHE CRONETHE ISLAND (1985)WHO'S THE KILLER
Ultimo film commentato
Ultimo post blog
OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater
Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater
Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...
Speciali
Ultime recensioni inserite
in sala
IL MAESTRO (2025)
 Regia: Andrea Di Stefano
Regia: Andrea Di StefanoInterpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia
Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
 Regia: Kathryn Bigelow
Regia: Kathryn BigelowInterpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller
Recensione a cura di The Gaunt
archivio
SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA
 Regia: Tim Fehlbaum
Regia: Tim FehlbaumInterpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier
Genere: drammatico
Recensione a cura di The Gaunt
NOSFERATU (2024)
 Regia: Robert Eggers
Regia: Robert EggersInterpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark
Genere: horror
Recensione a cura di Harpo
Ultima biografia inserita
Casualmente dall'archivio
Novità e Recensioni
Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!




 Fotografia strepitosa e recitazione notevole, meno curata la sceneggiatura. Fantastica la scena di sesso che si tinge di sangue.[SPOILER]
Fotografia strepitosa e recitazione notevole, meno curata la sceneggiatura. Fantastica la scena di sesso che si tinge di sangue.[SPOILER]

